giugno 2020

Il nostro giudice d’onore Roberta Di Pascasio ha scelto il suo podio di giugno facendosi guidare “dal senso di autenticità che ho sentito, dall’emozione e dalla tensione che mi hanno trasmesso, dalla coerenza di stile e linguaggio rispetto alla storia, e dalla capacità di inventio legata a un tema che consentiva una grande fantasia”.

1° classificato: “Stanza numero 5” di Simone Delos
Con un linguaggio essenziale, privo di qualsiasi compiacimento o enfasi ma che al tempo stesso riesce a regalarci uno sguardo umano e partecipe, la storia ci immerge fin dalle prime righe in un’atmosfera quasi onirica; i personaggi sono tratteggiati da un’unica parola illuminante eppure vivi, veri, così come il protagonista. Una stanza in cui curare i mali del nostro tempo, la rabbia e la depressione, dunque un racconto attuale e surreale insieme, originale nello stile e con un tocco di ironia che ne potenzia l’efficacia narrativa.
Intervista al nostro primo vincitore, il Breve Scrittrice Felice di giugno: Simone Delos
 “Entro dei limiti ben definiti, nel mio caso 60 minuti circa, riusciamo a trovare momenti di scrittura perfetti, strutture narrative perfette; oltre quei limiti, ciò che viene scritto rischia di suonare troppo simile a musica da ascensore.”. Don DeLillo.
“Entro dei limiti ben definiti, nel mio caso 60 minuti circa, riusciamo a trovare momenti di scrittura perfetti, strutture narrative perfette; oltre quei limiti, ciò che viene scritto rischia di suonare troppo simile a musica da ascensore.”. Don DeLillo.
E Don DeLillo non è soltanto uno degli scrittori americani più iconici dell’ultimo ventennio del ‘900, ma anche uno degli scrittori preferiti di Simone. Secondo solo, nella sua lista di gradimento, ad Alessandro Baricco.
Il nostro Breve Scrittore Felice di giugno scrive da tantissimo tempo, fin da quando aveva sei anni e sua mamma lo portava con sé al lavoro. Si sedeva in una stanza con una macchina da scrivere inutilizzata e batteva sui tasti cercando di raccontare le prime storie che covava dentro. Poi è cresciuto, e non è trascorsa una singola notte negli ultimi vent’anni in cui, prima di addormentarsi, non abbia plasmato nella mente una nuova storia da accarezzare all’indomani. Alcune sono finite sul foglio bianco, altre sono ancora in attesa, in quell’angolino segreto in cui ogni scrittore lascia decantare le ispirazioni.
“Stanza Numero Cinque” è nato allo stesso modo, sbocciando chissà da dove, dopo una notte premonitrice. Simone ci ha messo solo 10 minuti a scrivere il racconto vincitore, nessun passo indietro, nessuna correzione, nessuna modifica. Le sue sono tutte prime stesure, i “momenti di scrittura perfetti” di cui parla Don DeLillo, irripetibili, incorruttibili e autentici in ogni ansa, ogni virgola, ogni pausa o intenzione.
“Non ci riuscirei neppure a revisionare ciò che scrivo in quei raptus creativi, sarebbe come cambiare voce alla mia storia, snaturarla.”.
Quando ci parla di Baricco e dell’innovazione del linguaggio che ha portato nella letteratura italiana, il cerchio si chiude. Chi ama Baricco ama la forma delle parole ancor prima delle parole stesse, quella placenta sottile che riveste il contenuto per nutrirlo e proteggerlo allo stesso tempo. E Simone nei suoi racconti punta a fare lo stesso, a dar vita a gesti neri su fogli bianchi che dettino il ritmo delle emozioni di chi legge senza rimbombare, ma come un impercettibile battito cardiaco tra le righe.
Non ha mai seguito corsi, si è divertito a prendere in mano manuali di scrittura creativa e a leggere i racconti di Čechov e Carver, quest’ultimo, a suo avviso, “l’irraggiungibile punto più alto nella narrativa breve”.
Ha anche scritto tanto, compresa una raccolta di racconti, “Ventuno Rebirth”, adesso acquistabile su Amazon nella sua nuova edizione arricchita di due storie inedite.
A ottobre uscirà anche il suo primo romanzo per la casa editrice Bertoni Editore, e restando fedele al suo metodo che vive di trasporti creativi induplicabili, Simone ha scritto ogni capitolo rigorosamente di getto, cambiando una ventina di parole e basta dopo il punto finale.
Alzi la mano chi non prova un forte senso di invidia in questo momento…
Eppure ogni medaglia ha il suo rovescio e a volte una forte spinta creativa può essere immobilizzante quanto la paura del foglio bianco.
“Il vostro concorso per via della scadenza ravvicinata e del limite di parole mi aiuta ad essere concreto, a sedermi ancora davanti a quella macchina da scrivere e a non flirtare nel mondo delle idee e basta.”
Pensate che Simone, come regalo di matrimonio, dalle colleghe della madre ha ricevuto il primo racconto che aveva battuto a macchina a sei anni, su un vecchio foglio ingiallito di allora, chiuso da una coccarda. L’ha incorniciato e lo tiene in camera; Baricco agli esordi ha incollato al frigo un poster di “Viaggio ai confini della notte” di Céline per ricordarsi che la strada verso l’eccellenza era lunga, Simone quando guarda il suo primo racconto incorniciato ride e commenta: “Era una merda!”.
Ma spesso nella vita non ci serve altro che un monito a portata di mano che ci faccia tornare indietro al giorno da cui tutto ha avuto inizio.
Il racconto vincitore di Simone è un po’ questo, un monito che si leva dalla pagina e ci invita piano a vivere, ad essere imperfetti, usando il numero minimo di parole per farlo, toccando le corde giuste al tempo giusto.
La perfezione è un obbiettivo solo nella scrittura, un inseguimento iniziato tanto tempo fa quando Simone prendeva in mano i racconti di Edgar Allan Poe o Jules Verne dalla libreria di mamma.
“Forse chi scrive legge in maniera diversa. È tanto tempo che non leggo un romanzo solo per il piacere di leggerlo; mi ritrovo continuamente a vivisezionare frasi…”
Per nostra fortuna i suoi racconti sono così ipnotici da lasciar scivolare ogni voglia di bisturi a terra.
STANZA NUMERO CINQUE di Simone Delos
 Nella numero uno c’è il mago imbroglione. Nella due la figlia ribelle.
Nella numero uno c’è il mago imbroglione. Nella due la figlia ribelle.
Nella numero tre c’è il prete sensibile, nella quattro il chitarrista scordato.
La cinque è in ristrutturazione e nella sei c’è l’impiegato ruba stipendio.
La colazione si fa presto, nella terrazza.
Un unico tavolo, rettangolare. Sono tutti puntuali.
Il direttore mangia con gli ospiti, sorride, cerca di alimentare un qualche tipo di convivialità.
Il chitarrista insiste a voler essere chiamato Rapture. Proprio non lo accetta il suo nome. Troppo semplice: Antonio. Poco rock.
Di base servo caffè a tutti tranne che al prete. Lui si agita, dice.
A un certo punto il direttore parla alla figlia ribelle.
“Come ti senti stamattina”? lei non risponde.
Gliela vedi camminare negli occhi, la rabbia. Un paio di volte mi ha chiesto aranciata. Non ricordo altre parole sue.
L’impiegato ha questa camicia celestina. Si vede la canottiera sotto.
Ha il vizio di far cadere le cose: il bicchiere bagna il mago, il caffè macchia la figlia.
Lui si scusa, sempre. È un continuo chiedere scusa a tutti. Una mattina si è scusato per aver respirato troppo profondamente.
Il direttore ha sorriso come a dire, non c’è mica da scusarsi, a vivere.
L’hotel è piuttosto asettico, convenzionale.
C’è una reception (vuota), un ascensore, due sale per i pasti, una al chiuso una all’aperto. Un paio di divani messi ad L, con la televisione davanti (spenta).
Poi ci sono le camere, ma io non le ho mai viste.
Il mago fa casino. Si alza all’improvviso, ride con voce alta. Dice che sa leggere il futuro misurando la circonferenza degli avambracci.
Capita che prenda di mira il prete, o l’impiegato. Chiede soldi.
La volta che il chitarrista stava per venire alle mani, il direttore si è dovuto alzare.
La voce seria. Come a sgridare i bambini.
Io mi metto in disparte, tolgo le briciole dal tavolino.
Del resto cosa avrei potuto fare papà? Soldi per studiare non ce n’erano, giusto?
Credi che sia facile trovare lavoro? Oggi? In Italia?
Ma smettila dai. Pensa alla tua di vita.
Hai fatto forse meglio di me?
Il direttore mi mette le mani sulle spalle. Parla piano, come una musica.
Sono in un torpore strano. È quasi dormire.
Il tempo di capire che la stanza numero cinque è per me.
Apro gli occhi e siamo tutti seduti, storditi.
Qualcuno inizia ad alzarsi, a prendere la sua roba.
Fa parte del trattamento, non ricordare.
Ipnosi collettiva.
Qui si guarisce la gente dalla rabbia, dalla depressione.
Il dottore stringe qualche mano.
“Al prossimo giovedì”, dice.
Faccio un cenno con la testa ed esco anche io.
 2° classificato “126” di Stefano Palumbo
2° classificato “126” di Stefano Palumbo
Una storia delicata, infusa di luce e di nostalgia. Al lettore pare quasi di vederlo il protagonista nell’emozione di entrare nella stanza, nell’amore che prova a trovare la donna che lo aspetta, e soprattutto in un sorriso che sigla e racchiude una vita intera. Un racconto che guarda a un passato che non può tornare, a un amore perduto, alle cose finite, eppure il ricongiungimento è possibile in un finale che alla malinconia aggiunge un sorriso di soddisfazione per aver riassaporato la felicità e aver sconfitto, per un attimo, il destino.
Intervista al Secondo Classificato del contest di giugno: Stefano Palumbo
 Ogni volta che in redazione riceviamo un racconto di Stefano, ci domandiamo quale Stefano conosceremo, quale profumo ci sarà sulla pagina, quale personaggio resterà con noi dopo aver chiuso il computer.
Ogni volta che in redazione riceviamo un racconto di Stefano, ci domandiamo quale Stefano conosceremo, quale profumo ci sarà sulla pagina, quale personaggio resterà con noi dopo aver chiuso il computer.
Se c’è un motivo per cui la flash-fiction aiuta a crescere come scrittore è perché ti consente di sperimentare, di mandare per aria i meccanismi creativi utilizzati il giorno prima – a volte perfino lo stile – senza perdere la soddisfazione del punto finale, della compiutezza narrativa. Stefano ne approfitta ogni volta, e ogni volta è credibile, diverso e potente come i suoi “figli di carta”.
“La premessa doverosa che devo fare” – ci ha detto a proposito del suo racconto vincitore di giugno – “è che prima ancora di cercare uno spunto per la trama, cerco di decidere che tipo di clima emotivo avrà il mio racconto. Ovviamente, in questo gioca un ruolo fondamentale il finale, che sia lieto, triste, etc.
Personalmente ho una certa inclinazione ai finali poco canonici; c’è un’eccessiva predilezione per i lieti fini nelle narrazioni odierne, nonostante siano quelli più complicati da ottenere nella vita reale, così, contrariamente al mio solito, questa volta ho deciso in anticipo che avrei voluto dare alla storia un finale luminoso, ma declinato diversamente. Ho cercato di capire che cosa sia di preciso un lieto fine. Ne ho concluso che, a pensarci bene, a volte il vero lieto fine non è il “e vissero felici e contenti”, quanto il riuscire a concludere la propria esistenza soddisfatti di come la si è condotta. Da lì, la storia si è sviluppata praticamente da sé.”.
Gli ultimi minuti del Signor Petrelli, in “126”, sono tutti minuti “primi” che hanno dato alla sua vita un senso; ti sembra di accompagnarlo fin sull’orlo di un nuovo viaggio assieme allo staff medico, c’è una fine ma non c’è uno strappo, come se le vite vissute pienamente potessero lasciare una trama sottile nelle vite di chi toccano.
Una piccola magia su carta che funziona proprio perché ogni volta il clima emotivo che Stefano regala alla sua storia è autentico, mai indotto, o forzato, o preconfezionato.
126 di Stefano Palumbo
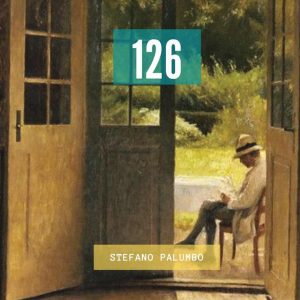 Era una bellissima giornata, pensò il signor Petrelli. Soleggiata, ma con un bel venticello fresco, di quelli che non ti fanno sudare. La ghiaia scricchiolò sotto la suola della sua scarpa, mentre scendeva dall’auto davanti alla pensione Campelli.
Era una bellissima giornata, pensò il signor Petrelli. Soleggiata, ma con un bel venticello fresco, di quelli che non ti fanno sudare. La ghiaia scricchiolò sotto la suola della sua scarpa, mentre scendeva dall’auto davanti alla pensione Campelli.
Tutto era esattamente come se lo ricordava. Un modesto edificio con la pietra a vista, dipinto di bianco e ocra. Fece scorrere lo sguardo sulla facciata pitturata di fresco e sul praticello che circondava la costruzione in un abbraccio verde brillante. E poi, lì in fondo, appena dietro quel filare di ulivi, il mare. Ne sentiva già l’odore nei polmoni. Inspirò a fondo, entusiasta.
Erano passati più di quarant’anni da quando era stato lì, ma sembrava come se fosse successo solo ieri. Il primo viaggio con Maria. Lei, lui e la loro 126 rossa, con le valigie legate sul tettuccio. Paolo, a quel tempo, era ancora soltanto un fagiolino nella sua pancia.
Si erano subito ripromessi di tornare l’anno successivo, ma lavoro, figli ed impegni avevano fatto slittare l’appuntamento sempre più in là. Maria era costantemente impegnata con la sua ditta, e lui aveva l’officina a cui badare. Ma ora, alla soglia dei settant’anni, era finalmente tornato.
“Buongiorno signor Petrelli!” lo salutò calorosamente la ragazza all’accoglienza. “È un piacere rivederla.”
“Anche per me, Roberta. È bello essere qui.” rispose con un sorriso.
La ragazza prese a consultare il voluminoso registro che teneva davanti, scorrendo i nomi con l’indice. Petrelli attese, paziente. C’era un rumore inusuale nell’aria. Una sorta di bip incessante. Doveva esserci un’apparecchiatura elettronica nascosta dietro il bancone.
“Portate il carrello!” decretò alla fine Roberta.
Petrelli la guardò, senza capire.
“Come scusi?”
“Ho detto, sua moglie è già arrivata. La attende.” ripeté Roberta. “Stanza 126.”
Petrelli annuì, divertito. Una coincidenza niente male, quel numero. Sorrise alla ragazza e si avviò lungo il corridoio, il borsone stretto nella mano.
Scorse con lo sguardo i piccoli numeri bianchi dipinti sulle porte delle camere. Quell’albergo era parecchio più grande di quello che ricordava. Il corridoio sembrava stendersi all’infinito davanti a lui, aprendosi in un alveare di minuscole porte marroncine. Fortunatamente, aveva sempre amato camminare, fin da quando era giovane. Lui e Maria ne avevano fatte, di passeggiate. Mare, montagna, non importava. Bastava far andare i piedi. Un corridoio d’albergo non era certo un problema. Non era mica così vecchio.
Avrebbe anche potuto godersi la passeggiata, se solo quel fastidioso bip avesse smesso di rimbombare per il corridoio.
Ed eccola lì. Stanza 126. I raggi del sole già sbucavano da sotto la porta della camera, illuminandogli le scarpe. Serrò la maniglia nella mano ed entrò. E lei era lì.
Maria gli sorrise, felice. Se ne stava sul letto con le gambe incrociate, la figura sottile immersa nella luce del sole che arrivava a fiotti dalla finestra. Immersi in quel chiarore, i capelli brillavano come oro. Tutto di lei brillava, che ci fosse il sole o no.
La guardò, imprimendosi quell’immagine negli occhi. Aveva scordato quant’era bella. Era talmente incantato da non sentire neanche il bip che aumentava di ritmo, fondendosi in un unico squillo ininterrotto.
“Servizio in camera!” esclamò, incapace di trattenersi.
Maria scoppiò a ridere, la mano sul ventre. Il rigonfiamento sotto la maglietta era quasi invisibile. D’altronde, era solo al quarto mese.
“Idiota.” ribatté, saltando su dal letto “Mettiti in costume, forza! Ho voglia di andare al mare!”
Petrelli ridacchiò, e fece cadere il borsone a terra. Poi chiuse la porta dietro di sé.
“Niente. È andato”
La dottoressa si tolse la mascherina, delusa.
“Ora del decesso, ventidue e trentaquattro.” decretò. “Pensavo di riuscire a riprenderlo, alla fine.”
“Anche io.” rispose l’infermiere, con aria triste. Spense l’ecocardiografo ed il suono metallico dell’apparecchio si interruppe. Erano passati solo dieci minuti da quando era stato solo un bip regolare. “Sembrava rispondere bene. Poi ha mollato di botto.”
“La famiglia?”
“Abbiamo avvertito i figli. Arriveranno tra poco.”
“Sposato?”
“Era vedovo. La moglie è morta una decina di anni fa. Una bella signora. Simpatica.”
La dottoressa fissò l’uomo. “La conoscevi per caso?”
L’infermiere annuì. “Il signor Petrelli? Altroché. È stato il mio primo meccanico. Anche mio padre portava l’auto da lui.” Fissò il volto dell’anziano, pensieroso. “Pensa, era andato in pensione solo da un anno. Un vero peccato.”
La dottoressa gli si affiancò, mettendogli una mano sulla spalla. Osservarono insieme l’uomo per qualche secondo.
“Ha il viso sereno.”
“Cosa?”
“Il viso…” ripeté la dottoressa. “Sembra sereno.”
L’infermiere guardò meglio. La donna aveva ragione. Sotto i baffi bianchi dell’uomo, si accorse, c’era inequivocabilmente un lieve sorriso soddisfatto.
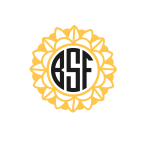
3° classificato “Buongiorno direttore” di Liger
Un viaggio via via più allucinato nella mente del protagonista, da quando è un bambino ossessionato dagli alberghi e dalle loro dinamiche umane e lavorative, a quando è un adulto che riesce a rendere reale quella ossessione, in un crescendo inquietante fino al finale inaspettato e sorprendente nella sua venatura noir. Originale e sorretto da una scrittura consapevole, lascia una domanda: fino a che punto riusciamo a spingerci per realizzare i nostri sogni?
Intervista al Terzo Classificato del contest di giugno: Liger
 La nostra chiacchierata con Liger sembra una conversazione tratta da un romanzo poliziesco.
La nostra chiacchierata con Liger sembra una conversazione tratta da un romanzo poliziesco.
Botta e risposta, e poi pausa. E poi ancora botta, risposta e pausa.
Qualcuno ha detto che il lavoro del giornalista è quello di riconoscere ciò o chi si ha davanti, e Liger è giornalista da vent’anni. Ci scruta attraverso le nostre domande, ricerca possibili angolature e si lascia andare quando al centro del discorso c’è il suo racconto, non chi l’ha scritto.
Fa piacere in un mondo di ego-maniacalità imbattersi in qualcuno che dà ancora importanza alle parole scritte e non al proprio riflesso in controluce, in qualcuno che ha a cuore il come si riempiono gli spazi bianchi, che sia per un articolo di sport, o di teatro, o per dar vita al protagonista più ossessionato dagli alberghi nella storia della narrativa breve.
“Da piccolo avevo il gioco in scatola Hotel; quello è tutto quanto ho in comune con il mio protagonista, le analogie si fermano lì. Non ho mai sognato né di lavorare in un albergo, né tantomeno di dirigerlo…”.
Il finale è stata la prima cosa di cui era certo, il punto di partenza, un colpo di scena thriller che doveva stupire il lettore nelle ultime righe, il resto l’ha costruito con metodo in una mezzora.
In fondo quando scrivi per lavoro, la dimestichezza con la struttura, con il ritmo e la quantità di dettagli che servono ad ancorare la narrazione ce l’hai allenata, l’ambientazione noir l’ha aiutato a sentirsi a casa.
Liger ha iniziato a leggere i gialli di Agatha Christie a 9 anni, per poi approdare ai romanzi di Stephen King, passando per James Patterson, la penna americana famosa soprattutto per aver dato vita alla serie sul detective/psicologo Alex Cross.
“Vi seguo più o meno da settembre, ma ogni volta non trovavo il tempo o il coraggio di gettarmi. Non avevo mai partecipato ad un concorso letterario prima e di sicuro non mi immaginavo di ottenere un risultato così buono alla prima partecipazione. Ho visto la traccia sull’albergo e mi è subito balenata in testa un’idea, a quel punto mi sono buttato ed è stato più facile che scrivere un articolo di giornale.”.
È stato così facile che Liger ha intenzione di prendere parte ad un prossimo concorso, magari misurandosi con un genere con cui ha meno dimestichezza o con una narrazione in terza persona al posto dell’io narrante che ha scelto per il suo esordio.
La fiction letteraria ha questo di bello: è liberatoria, è una metafora di vita o di pensiero a cui tiriamo noi i fili, non è tenuta a rispettare la verità al pari dell’informazione giornalistica, è più simile a uno spettacolo di magia su carta, l’importante è che non si vedano i trucchi.
E Liger di trucchi se ne intende: non solo ama lo sport più teatrale su tutti, il wrestling – e utilizza come pseudonimo il nome di un wrestler giapponese che ha intervistato anni fa – ma gestisce anche un sito sul teatro che si chiama milanoteatri.it.
Quando il suo racconto è stato pubblicato sulle nostre pagine social, non ha avuto il coraggio di condividerlo subito; chi prende sul serio le parole e la creatività teme sempre per il futuro di quelle che meticolosamente ha messo in fila per gli altri.
“Mi spaventa andare oltre il racconto breve…” – ci ha detto pungolato dalla nostra insistenza – “L’idea di un romanzo per ora mi blocca.”
Philip Roth diceva: “In un’era come la nostra, in cui tutti provano a convincerti, a tentarti, o a controllarti, la fiction letteraria aiuta a liberarsi da quel ronzio di fondo.”.
Liger non sembra nemmeno sentirlo.
Buongiorno direttore di Liger
 Gli hotel mi hanno sempre affascinato, fin da quando ero bambino. Non sono mai stato in alberghi di lusso, ma anche il due stelle in cui i miei genitori mi portavano per passare una settimana al mare mi lasciava a bocca aperta. Quel salone da pranzo così grande ai miei occhi era un parco dei divertimenti, nulla a che vedere rispetto alla saletta della nostra casa in periferia. Chiedevo sempre di sederci in uno dei tavoli laterali così avevo una visione della sala a 360°. E le camere? Già il fatto che per una settimana mia mamma non mi dicesse “Metti in ordine la tua stanza” era una meraviglia. La sera insisteva affinché andassi nella sala giochi con gli altri bambini, ma io preferivo passeggiare per i corridoi, spiare i lavoratori e studiare i loro movimenti. Purtroppo la magia durava una settimana poi si tornava alla vita di tutti i giorni, ma io non abbandonavo mai gli hotel. Giocavo facendo finta che i pupazzi fossero i clienti, l’orsacchiotto e l’anatra erano una coppia di giovani sposi, il toro un agente in trasferta di lavoro. Assegnavo a ognuno la propria camera, con chiavi finte, e servivo ogni mattina la colazione. Appena si presentava un piccolo guasto correvo a sistemarlo, fino a quando non ho assunto il leoncino a darmi una mano in reception e la giraffa a servire in sala. Nel 1987 avevo 11 anni quando la mia infanzia ha avuto la svolta. Il merito è del gioco in scatola “Hotel”. Obbligavo i miei genitori a giocare con me e quando non potevano giocavo da solo, ero grande per usare i pupazzi, sono passato direttamente agli amici immaginari. Quelli veri non mi piacevano. Tiravo i dadi per ognuno di loro cercando di essere imparziale e non auto favorirmi. Costruivo hotel, aggiungevo piscine, campi da tennis, alzavo le tariffe. Un sogno. A 19 anni ho lasciato mia famiglia per andare nella capitale a studiare economia e lì ho visto lui. “Royal Hargrave Hotel” con affianco 5 stelle. Una struttura imponente color mattone con due torrette alle estremità. Ho sempre preferito gli hotel storici a quelli moderni. All’ingresso due concierge in divisa raccoglievano le valigie dei clienti. Sono entrato e ho compilato un foglio con il mio curriculum. Due mesi dopo avevo abbandonato l’università ed ero in divisa davanti all’hotel a scaricare valigie. Liam, uno dei due congierge che vidi quel giorno, era stato sfortunatamente investito da un’auto; così mi chiamarono. Dopo un breve periodo fui assunto, convinsi sia il capo dei facchini George, sia il direttore Hanson. George fu come un secondo padre per me, quando venne a farci visita la duchessa di Gloucester, George era a letto con un forte mal di pancia, toccò a me accoglierla.
Gli hotel mi hanno sempre affascinato, fin da quando ero bambino. Non sono mai stato in alberghi di lusso, ma anche il due stelle in cui i miei genitori mi portavano per passare una settimana al mare mi lasciava a bocca aperta. Quel salone da pranzo così grande ai miei occhi era un parco dei divertimenti, nulla a che vedere rispetto alla saletta della nostra casa in periferia. Chiedevo sempre di sederci in uno dei tavoli laterali così avevo una visione della sala a 360°. E le camere? Già il fatto che per una settimana mia mamma non mi dicesse “Metti in ordine la tua stanza” era una meraviglia. La sera insisteva affinché andassi nella sala giochi con gli altri bambini, ma io preferivo passeggiare per i corridoi, spiare i lavoratori e studiare i loro movimenti. Purtroppo la magia durava una settimana poi si tornava alla vita di tutti i giorni, ma io non abbandonavo mai gli hotel. Giocavo facendo finta che i pupazzi fossero i clienti, l’orsacchiotto e l’anatra erano una coppia di giovani sposi, il toro un agente in trasferta di lavoro. Assegnavo a ognuno la propria camera, con chiavi finte, e servivo ogni mattina la colazione. Appena si presentava un piccolo guasto correvo a sistemarlo, fino a quando non ho assunto il leoncino a darmi una mano in reception e la giraffa a servire in sala. Nel 1987 avevo 11 anni quando la mia infanzia ha avuto la svolta. Il merito è del gioco in scatola “Hotel”. Obbligavo i miei genitori a giocare con me e quando non potevano giocavo da solo, ero grande per usare i pupazzi, sono passato direttamente agli amici immaginari. Quelli veri non mi piacevano. Tiravo i dadi per ognuno di loro cercando di essere imparziale e non auto favorirmi. Costruivo hotel, aggiungevo piscine, campi da tennis, alzavo le tariffe. Un sogno. A 19 anni ho lasciato mia famiglia per andare nella capitale a studiare economia e lì ho visto lui. “Royal Hargrave Hotel” con affianco 5 stelle. Una struttura imponente color mattone con due torrette alle estremità. Ho sempre preferito gli hotel storici a quelli moderni. All’ingresso due concierge in divisa raccoglievano le valigie dei clienti. Sono entrato e ho compilato un foglio con il mio curriculum. Due mesi dopo avevo abbandonato l’università ed ero in divisa davanti all’hotel a scaricare valigie. Liam, uno dei due congierge che vidi quel giorno, era stato sfortunatamente investito da un’auto; così mi chiamarono. Dopo un breve periodo fui assunto, convinsi sia il capo dei facchini George, sia il direttore Hanson. George fu come un secondo padre per me, quando venne a farci visita la duchessa di Gloucester, George era a letto con un forte mal di pancia, toccò a me accoglierla.
George non era presente neanche quando nel 1999 ospitammo i Rolling Stones venuti in città per il loro No Security Tour. Purtroppo il vizio del fumo era la sua debolezza e fu una terribile notizia quando fu trovato morto nel suo appartamento; c’era da aspettarselo. Viveva da solo e un’embolia lo ha stroncato. Toccò a me prendere il suo posto alla guida della squadra dei facchini, aumentò lo stipendio, ma i soldi non erano un problema, la stanza che il Royal Hargrave Hotel mi metteva a disposizione era tutto ciò di cui avevo bisogno, conoscevo ogni piccolo anfratto dell’albergo.
Iniziavo, però, a sentirmi limitato in quel ruolo alla porta dell’hotel. Da bambino sognavo il contatto diretto coi clienti, non solo il benvenuto nello scaricare i bagagli. Lo feci notare a mister Hanson e disse che avrebbe tenuto conto della mia richiesta. Ho dovuto aspettare quasi due anni ma, quando Lewis della reception fu scoperto a rubare nella stanza del deposito bagagli, arrivò la mia occasione. Avevo realizzato un altro sogno. I clienti mi adoravano, ero pronto a soddisfare ogni richiesta, gli abitudinari della struttura facevano sempre il mio nome a mister Hanson chiedendo che fossi io ad occuparmi di loro. Gli anni passavano e anche la proprietà ormai sapeva bene chi fossi ed era più che mai soddisfatta dei miei servizi. E allora perché fermarmi? Giro lo sguardo e vedo l’ufficio di mister Hanson, la scrivania con sopra il suo nome. Io potrei essere il direttore del Royal Hargrave Hotel? Sì potrei. Un’auto di notte può investire un passante. Un’iniezione di aria può provocare un’embolia. Un uomo può essere accusato ingiustamente di furto.
“Tu sei pazzo” mi dice mister Hanson con l’ultimo respiro mentre le mie mani si stringono attorno al suo collo.
MENZIONI D’ONORE

UN URLO NELLA NOTTE di Ilaria Romano
A volte, quando si scrive, il ritmo è tutto; quello e la capacità di strizzare l’occhio al lettore e tenerlo sulla pagina fino al punto finale. Ilaria ci ha “fregato” dalla prima riga.

Il quadro di Fontana di Luisa di Toma
Ci è mancato poco che il racconto finisse sul podio; un quadro iconico protagonista, una receptionist tratteggiata bene e il presagio della normalità in sottofondo. Il legame tra la voce narrante e quel taglio in mezzo a una tela il segreto di questa piccola grande storia di ordinaria follia.

Il Klinik di Rosa Varani
Non solo è scritto bene, ma ci regala “il senso della vita”. Di questo si tratta quando si parla di scrittura creativa: si mette in fila, stilosamente, la propria metafora dell’esistenza, perché qualcuno la raccolga.
GIURIA POPOLARE DI GIUGNO
Il testa a testa di giugno è stato tra Luisa Di Toma con “Il Quadro di Fontana” e “Stanza Numero 5” di Simone Delos. Ha vinto Luisa con 71 like complessivi contro i 54 di Simone. Diretti inseguitori: Stefano Palumbo con 23 like per il suo “126”, immediatamente dietro Barbara Valentina Conte con “Sana Follia” e quinta nella giuria popolare si è classificata Ilaria Romano con “Un urlo nella notte”.
Partecipa!
Iscriviti e partecipa!
La partecipazione richiede un pagamento di 10€ e la registrazione al sito, che la prima volta avverrà in fase di checkout.