febbraio 2020

La medaglia d’oro per il nostro giudice d’onore Ettore Andenna va a Paola Merzaghi per il suo ricordo di una donna che vive un momento di evasione totale, con la determinazione che la definisce, per farle affermare che, nonostante gli impegni di madre e moglie, ha il dovere di sentirsi viva e combattente per sé stessa, per essere sempre forte anche per gli altri. Una descrizione lucida ed appassionata di sensazioni ed emozioni di un evento in cui ha voluto mettersi alla prova per confermare “Io ci sono”.
Intervista al nostro primo vincitore, il Breve Scrittrice Felice di settembre: Paola Merzahi
 Qualcuno ha detto che un giornalista è colui che sceglie di avvicinarsi il più vicino possibile al cuore del mondo; Paola è una giornalista inconsapevole, la sua scrittura nasce da una spinta inconsapevole, lei la definisce facile come respirare. E invece è il suo modo istintivo di dare senso alle cose, di guardarle fisse negli occhi prima che buchino la sfera interiore e si mischino con il bagaglio della vita quotidiana sfuocandosi.
Qualcuno ha detto che un giornalista è colui che sceglie di avvicinarsi il più vicino possibile al cuore del mondo; Paola è una giornalista inconsapevole, la sua scrittura nasce da una spinta inconsapevole, lei la definisce facile come respirare. E invece è il suo modo istintivo di dare senso alle cose, di guardarle fisse negli occhi prima che buchino la sfera interiore e si mischino con il bagaglio della vita quotidiana sfuocandosi.
“Scrivere per me è un modo per stare bene, per restare in contatto con le mie emozioni. Solo appiccicandole su un foglio riesco a vederle davvero.”.
Tutto è partito con le prime lettere che si scambiava con le compagne di scuola, poi è diventata la sua forma di comunicazione privilegiata.
“Se devo dire qualcosa a qualcuno, glielo scrivo. Se voglio esprimere quello che penso su un determinato argomento, devo metterlo per iscritto.”.
E infatti da circa quattro anni tiene un blog per un numero chiuso di amici in cui cerca di avvicinarsi al cuore del mondo a modo suo, raccontandolo prima a se stessa e poi agli altri.
La necessità di capire e di metabolizzare pensieri mischiati alle sensazioni è la ginnastica degli autori, anche quelli sommersi in altri mondi, in altri ruoli, in altre priorità.
Quando Paola ha partecipato alla sua prima maratona, quel bisogno ha bussato alla sua porta di mamma più forte delle altre volte, e così ha iniziato a correre; non per rimettersi in forma, o per riaffermare la sua centralità nella propria vita, ma per dialogare di nuovo con se stessa.
“La corsa per me è pensiero. Il tempo della corsa è il tempo del riflettere sorretto da un movimento ritmato che mette ordine ai pensieri.”. E a furia di mettere ordine ha corso sette maratone in un anno e mezzo.
Ha scritto anche “16oo testi” su quell’esperienza, uno di quelli che ha sentito più suo il racconto che ha inviato alla nostra redazione come amarcord significativo della sua esistenza.
Ci ha commosso con 750 parole, con una scrittura lineare, candida, esistenziale, che crede di più alla poesia nascosta negli attimi puri del mondo, piuttosto che in quella forgiata negli stampi raffinati e autorevoli di chi ha rinchiuso il sentire in parole scritte per e prima di noi.
“Detesto gli scrittori pomposi, e non vorrei mai provare ad essere uno di loro. Io non ho neppure finito l’Università, non ho mai fatto un corso di scrittura e faccio a pugni con l’ortografia. Sono un’autodidatta che scrive d’istinto, senza pose, senza filtri; l’unico scopo è arrivare al fulcro della mia anima.”.
Adora le penne giapponesi perché sono equilibrate ma intense; e ama anche la scrittura asciutta dei nordici, in particolare quella di Bjorn Larrson, perché farcisce le pagine di sue riflessioni personali, ammorbidendo l’impasto letterario.
Prima dell’ultimo anno complicato di vita, che Paola, con sense of humour, ha ribattezzato il suo “Ground Zero”, leggeva un libro alla settimana: Irving Stone con i suoi “Tormento e l’estasi” sulla vita di Michelangelo e “Brama di vivere” incentrato su Van Gogh, ma anche Irvin Yalom con “Le lacrime di Nietzsche” e la “La cura Shopenhauer”, quasi tutto Jonathan Coe, le biografie di Dora Maar e Lou Salomè, ma anche gli italiani Carofiglio ed Erri De Luca.
“Del primo amo il tipo di scrittura, al secondo vorrei potergli stringere la mano un giorno.”.
Paola non se ne rende conto, ma quando legge fa la stessa cosa che le viene naturale davanti al foglio: cerca la verità, il famoso midollo della vita, che sia quello di donne che hanno inciso i tempi, il suo, o quello delle proprie amiche, di Silvia, di Anna, compagne di maratona così ben tratteggiate nel suo racconto vincitore che ognuno di noi è stato tentato di dare loro un volto.
Ci sono tanti modi di scrivere, tante razze di scrittori là fuori, e di gruppi sanguigni, ma c’è un unico spartiacque che separa i lettori dagli scrittori: la volontà di far correre la mente su terreni ignoti, sdrucciolevoli, mai calpestati da altri, un tipo di fiato interno che non teme né le salite, né le discese, solo le scelte imposte dagli altri.
Paola sembra nata per far disputare ai suoi pensieri una maratona, per non avere paura del foglio bianco, anzi per raccogliere la sua sfida e traghettare le parole scritte fino al taglio del traguardo, che sia un post del suo blog, o uno dei mille racconti che batte sulla tastiera per scoprire il vero aspetto che ha il suo dentro davanti allo specchio e l’autentico sapore delle cose. Di tutte le cose.
“Sento che la scrittura è quella cosa che prima o poi mi salverà la vita, un fiume su cui io navigherò per andare lontano.”.
Quello che lei non sa – o non vuole sapere – è quanto la sua scrittura potrebbe salvare gli altri.
Amarcord di una mamma maratoneta di Paola Merzaghi
 Il portellone dell’aereo si apre e ci ritroviamo in primavera.
Il portellone dell’aereo si apre e ci ritroviamo in primavera.
Il tepore ci disarma immediatamente della nostra invernale rigidità milanese.
Valencia ci lascia arrese; lo sapevamo che nulla sarebbe stato mai più come prima.
Tre donne, tre madri, tre incoscienti guerriere della felicità, ostinate a svoltare nuovi angoli, convinte che la vita riservi ancora sorprese, sempre che ci si metta in gioco personalmente.
Tre pazze, oppure tre devote della vita, che celebrano in ogni sua più preziosa sfumatura, come fosse una preghiera.
L’esistere è un crogiolo dove si fondono liquide emozioni, passioni, rabbie, amore, paura, sogni e delusioni. Un fuoco sempre acceso muove sostanze di chimica e poesia che sorseggiamo davanti allo spettacolare orizzonte dei nostri anni che passano.
Mi sbottono la giacca e decido di provarci davvero a fare questa maratona. La prima della mia vita. Senza preparazione, senza logica, senza speranza; solo frammenti di me, di quello che sono, dei miei desideri, della mia disperazione, del mio coraggio, e della mia sfacciataggine.
42 chilometri sono il mio Everest.
Parto con un paio di scarpe da runner, ma senza ramponi, senza guanti, senza occhiali, senza ossigeno. Mani nude che graffiano il ghiaccio, occhi accecati da una luce che è già troposfera, polmoni come sacchetti di plastica riempiti di tanta inutile allegria.
27 mila persone attendono il via. Persone ovunque, davanti, dietro, addosso, vicine, lontane. Cuori che battono.
Metto i piedi sui primi dieci metri di asfalto. Penso: me ne mancano 42 mila.
Noi amiche facciamo qualche chilometro insieme, come a volerci sorreggere nell’impatto emotivo devastante.
Poi Silvia parte, lei e la sua forza prorompente. Mentale, fisica. La vediamo sparire fra migliaia di persone come una stella cometa che scompare in una galassia di piccole stelle.
Silvia corre e vive così, e tu rimani incantato come davanti ai fuochi d’ artificio, con il naso all’insù.
Anna è la saggia del gruppo, l’equilibrio che mette in asse i muri dei nostri fantasiosi castelli. Mi allineo al suo passo, al suo respiro. In una silenziosa danza in cui volano 30 km come leggere note musicali su un pentagramma d’asfalto.
Poi arriva: il momento di stare sola.
Ho davanti 12 infiniti, interminabili, assurdamente dolorosi, improponibili, maledetti chilometri.
Io davanti alla vetta dell’Everest, senza guanti, senza ramponi.
Non posso tornare indietro. Non posso camminare perché le gambe, appena si raffreddano, mi fanno male di un male insopportabile.
Scatta la “scelta di correre”, non l’obbligo di farlo. È questo il perno centrale di una maratona.
Per correre 42 chilometri devi scegliere e non subire una scelta.
Per vivere il principio è lo stesso.
Puoi farti trascinare dalla folla, puoi strisciare, puoi abbandonare, puoi camminare. Ma rischieresti di smettere idealmente di esistere.
Per provare a vivere davvero devi scegliere di farcela.
La maratona me l’ha insegnato, me l’ha ripetuto per 5 ore e 2 minuti.
La maratona è un incontro ravvicinato con la verità. È la gestazione e il parto di se stessi.
La maratona, per una madre con le gambe e i fianchi ammorbiditi dalle gravidanze, dalle cene con gli amici, dalle nottate trascorse ad allattare, dai compiti la domenica, dagli spalti di cemento dei saggi da guardare, è una corsa fra i campi di girasole, un bagno nell’aurora boreale, un giro di valzer con gli Dei, una piscina di fragole mature, il sorriso dei nostri figli, l’Ave Maria di Schubert in una chiesa, il sole che si scioglie nel sale del mare, l’arcobaleno addosso, l’amore di notte, le risa degli amanti nei vicoli stretti di medioevali città.
Scelgo di farcela.
Scelgo di amare.
Scelgo di regalarmi la felicità.
Passo sotto allo striscione con su scritto FINISH, ma paradossalmente è il mio più grandioso START.
Mi sciolgo in lacrime; è il mio corpo che evapora fra gocce di salmastra completezza.
Chiamo casa, i figli sentono una madre che piange di gioia. Rimangono spaesati, ed orgogliosi.
Il sapore amaro del rimmel mi bagna le labbra.
Mi mettono al collo una medaglia, tra le mani 5 mandarini.
In quel momento sono un carico pesantissimo davanti alle mie residue forze. Vorrei portarli con me perché sono il mio premio, ma sono costretta a lasciarli giù.
Li appoggio su una panchina sperando che qualcuno li apprezzi al posto mio.
Sono felice. Di una felicità piena.
Scalare l’Everest a mani nude sa di incoscienza e di saggezza.
Vincere una sfida sa sempre d’amore, qualsiasi sia la sfida che scegliete di intraprendere.

Il secondo posto va a “La partita a biglie” di Luke Skywalker.Un amarcord emblematico di un periodo di vita che ha contrassegnato generazioni di ragazzi sulle spiagge, descritto con la passione che si viveva in quel tempo, meno tecnologico rispetto a quello di oggi, ma pieno di emozioni più semplici e socialmente più coinvolgenti.
Intervista al Secondo Classificato del contest di febbraio: Luke Skywalker
 Il nostro Breve Scrittore Felice di agosto 2019 ci ha riportato al mare.
Il nostro Breve Scrittore Felice di agosto 2019 ci ha riportato al mare.
“Perché quelle partite di biglie sulla sabbia erano la cosa più divertente al mondo. E non tanto, o non solo la partita in sé, ma soprattutto la preparazione della pista.
Più di due ore per scegliere la ragazzina con il didietro giusto, per scavare, per compattare le paraboliche con i palmi delle mani. Chi correva a riempire i secchi d’acqua, chi plasmava rettilinei… Era il mondo prima che si complicasse tutto, prima delle fidanzate, prima delle liti, prima delle morti. Se potessi tornare indietro una volta sola, tornerei a quel giorno d’estate.”
Fellini adorava i lapsus di coscienza, gli attimi di perpetua adolescenza rubati al presente.
Il racconto di Luke Skywalker è esattamente tutto questo ed è autenticamente italiano, come i film di Fellini.
La partita a biglie di Luke Skywalker
 Estate, anni 80, Liguria, amici per sempre.
Estate, anni 80, Liguria, amici per sempre.
Oggi si fa il pistone!
La colazione di nonna Fina fa abbastanza schifo, come al solito, però ti voglio bene lo stesso perché tra poco si va in spiaggia.
Il sacchetto di biglie come per magia è uscito dall’armadio, ho già controllato lo stato delle mie “gialle” almeno una decina di volte.
Per me e Max sono le Renault della Formula1, poco importa che mostrino le foto di Battaglin e Felice Gimondi.
Quest’anno vinceremo noi, la tattica l’abbiamo studiata bene, l’ho ripetuta un centinaio di volte ieri nel briefing vicino allo scivolo.
Max partirà forte, si prenderà i maggiori rischi e tenterà la fuga; io non dovrò forare nemmeno una volta se voglio avere una chance. Rimarrò nel gruppo degli inseguitori, posizionandomi nei punti strategici per ostacolarli nelle chicanes.
Abbiamo programmato l’arrivo in parata, o perlomeno una doppietta che nessuna coppia é mai riuscita a realizzare nelle edizioni precedenti.
Suona il citofono, finalmente ci siamo… “Ssendo subito!”.
Piero ha già fatto la ricognizione tra le stuoie ed ha individuato la ragazzina col fondoschiena adatto per tracciare il percorso.
Claudio ci illustra il circuito disegnandolo con lo stecchino del ghiacciolo sulla sabbia; ieri lo ha dovuto modificare una ventina di volte per accontentare tutti.
Un solo mega rettilineo per i “ditalunghi”, niente trappole strane o tunnel che il Mark Spitz di Milano prova sempre a proporre, e soprattutto l’unaniminità sulle due parabole da almeno trenta centimetri di altezza.
La nostra pista di biglie sarà l’invidia di tutti i bagnanti!
La fase della costruzione è quella più estenuante, ma dopo un inverno lontani serve a farci tornare amici per sempre.
All’inizio siamo solo noi, sette o otto gagni sotto il sole, armati di secchielli e coi palmi delle mani più veloci di Ponente.
Ma dopo una ventina di minuti iniziano ad arrivare gli altri, i “grandi”, che da consiglieri si trasformano nei più abili artigiani di piste di sabbia.
Da tre secchielli si passa a cinque e poi a dieci, le paraboliche prendono forma sotto gli occhi di mezza spiaggia, anche quelli che passeggiano sul bagnasciuga si fermano a dare il loro contributo.
Le iscrizioni si sono chiuse ieri: “Ci spiace, ma non si accettano altri concorrenti!”.
C’è Andrea Il Rosso, c’è Lorenzo assieme a lui con le McLaren verdi, Giorgio e Piero con le rosse di maranello, Claudio e Simone con le Matra Blu, Andrea ed il Capitano con le Williams bianche, ed infine Prost e René Arnoux.
Un rapido sorteggio per determinare la griglia, un ultimo tuffo prima della partenza e ai vincitori il sacro diritto a distruggere la pista.
Per un’ora scarsa ci siamo solo noi al mondo.
Giorgio ed il suo personalissimo colpo col pollice, il sorriso caloroso che ha sempre fatto a pugni con lo sguardo di ghiaccio.
Il Capitano era già un ometto, quello capace di non vincere per lasciare ai più sfigati un momento di gloria, “sempre che se lo siano meritato, va bin?”.
Un affetto incondizionato che anche dopo più di trent’anni mi fa passare dal sorriso al pianto e ancora al sorriso nello spazio di un amen.
Con gli altri, almeno, posso ancora berci un caffé e condividere i ricordi.
Comunque quell’estate, non avevo forato nemmeno una volta e Max non si era fatto prendere…
Ancor oggi, quando torno da quella spiaggia verso ferragosto, mi ritrovo a pensare che da qualche parte, in cantina, il sacchetto di biglie ci sarà sempre.
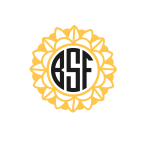
Il terzo posto va senza dubbio a un racconto tecnicamente e stilisticamente ineccepibile: “Un paese sospeso nel tempo” di Virginia Coral.
Il tema è L’Amarcord di Fellini e l’autrice lo rispecchia mirabilmente con un ricordo classico e molto ben ricostruito nelle sensazioni e nelle immagini, che, come poi si spiega nel racconto restano “sospese nel tempo”.
Intervista al Terzo Classificato del contest di febbraio: Virginia Coral

La più felliniana del contest nel vero senso dell’aggettivo: ossia in possesso del terzo occhio che aveva Fellini, quello capace di vedere l’invisibile e di raccontarlo.
“…vecchi banchi di legno, schierati sull’attenti come un manipolo di soldati…”
Si meritava un posto sul podio anche solo per questa riga.
“Alle medie, sullo stesso argomento, avevo fatto un tema che poi era stato letto in classe. Anche la prof lo aveva trovato molto carino… Sono i miei primi ricordi e se ci penso adesso l’atmosfera allora era simile al 900 di Bertolucci. Sembra siano passati secoli.”
Virginia Coral era già stata la nostra Breve Scrittrice Felice del luglio scorso. E non smette di produrre racconti perfetti, di soffiare bolle di letteratura nell’etere che noi inseguiamo rapiti, dimenticandoci del qui e dell’adesso.
Un paese sospeso nel tempo di Virginia Coral
 Un paese assopito nella polverosa pianura veneta. Afa e mosche sulle strade sterrate che si perdono tra i campi. Distese di spighe dorate spruzzate di papaveri, piante di granoturco e contadini sudati, curvi sotto la calura. Questo il set dei miei ricordi più lontani.
Un paese assopito nella polverosa pianura veneta. Afa e mosche sulle strade sterrate che si perdono tra i campi. Distese di spighe dorate spruzzate di papaveri, piante di granoturco e contadini sudati, curvi sotto la calura. Questo il set dei miei ricordi più lontani.
Trascorrevo i mesi estivi nella scuola, dove mia nonna viveva e lavorava come bidella. Le aule vuote avevano grandi finestre e vecchi banchi di legno, schierati sull’attenti come un manipolo di soldati. L’odore d’inchiostro e di muffa si fondevano. Alle spalle della cattedra era appesa una vecchia lavagna scolorita. Il gesso aveva riempito le porosità dell’ardesia e il tempo ne aveva inciso la superficie con solchi profondi. Allora non ne ero consapevole, ma l’atmosfera era la stessa dei romanzi di Dickens.
Sul lato sinistro dell’edificio, al piano terra, uno stanzone fungeva da biblioteca. Era simile al magazzino di un negozio fallito, ma per me quel luogo era più irresistibile delle segrete di un castello. Passavo ore tra i libri disseminati sul pavimento o sistemati nei pochi armadi sgangherati. Dalle persiane chiuse filtrava una luce giallognola. Entravo furtiva, in punta di piedi, quasi fossi un ladruncolo in cerca di qualche moneta d’oro. Respiravo l’aria calda, impregnata di umidità. Mi guardavo in giro con un misto di paura e devozione, afferravo un paio di sussidiari sgualciti, chiudevo con cura la porta e correvo lungo il corridoio, fino all’uscita. Mi sedevo sulle scale, all’ombra, mentre le cicale frinivano, ignare che la loro stagione stava volgendo al termine.
Non sapevo ancora leggere, ma mi piaceva sfogliare le pagine e annusare il profumo della carta. Dovevo essere molto piccola, perché sentivo il peso di quei libri sulle gambe, mentre toccavo le figure sbiadite e percorrevo i rosari di sillabe, che allora mi parevano una ininterrotta sequela di segni misteriosi.
La scuola era circondata da un cortile di ghiaia bianca, che scricchiolava sotto le suole dei sandaletti di stoffa. Il cancello si apriva sullo stradone, che la domenica la nonna ed io percorrevamo per andare a messa al centro del paese. Ai lati correvano fossi poco profondi, che il sole d’agosto trasformava in rigagnoli d’acqua fangosa.
Nel cuore del paese, poco più di uno slargo, si aprivano le poche botteghe, che si accollavano l’onere di soddisfare bisogni e desideri degli abitanti. L’emporio pareva l’antro di un rigattiere. Alle pareti erano allineati sacchi di zucchero e di farina e dal soffitto pendevano grappoli di zoccoli e rotoli di carta moschicida. A fianco c’era l’osteria con i tavolini sistemati all’ombra di un bersò di foglie di vite. Al lato opposto si trovava il negozio di dolciumi. Una grande vetrina lasciava intravvedere il bancone di fòrmica grigia sul quale vasi pieni di caramelle colorate adescavano i bambini.
La piazzetta era un crocevia di strette vie sassose e di velenose maldicenze. Si parlava a mezza voce della sconveniente malattia del mugnaio, che gli impediva di ingravidare la giovane compagna, delle botte che l’oste riservava alla moglie quando tornava ubriaco, della figlia illegittima che la generosa gelataia aveva portato in dote al marito. Bisbigli di provincia, contorti residui di appetiti delusi, affidati a sguardi untuosi e labbra taglienti.
Le insinuazioni non risparmiavano neanche il parroco, che, secondo molti, prestava più attenzione ai seni prosperosi delle ragazze, che ai loro peccati veniali. Qualcuno mormorava che Don Fausto avesse pensieri audaci mentre sbirciava nelle scollature degli abiti di mussola, leggeri come le ali delle falene. Si diceva che le sue dita sudate si avvicinassero inquiete a quel cibo tanto appetitoso, quanto proibito. L’ostia e il vino durante l’Eucarestia non placavano la sua fame.
La paura dell’inferno era più forte della stravagante integrità del prete. Così l’intero paese si ritrovava la domenica mattina per la messa grande e percorreva la stradina di ciottoli bianchi che portava alla chiesa. Fin da allora, il richiamo della fede era troppo flebile perché potessi sentirlo. Sedevo annoiata sugli scomodi banchi guardandomi intorno e inspirando i vapori dell’incenso. Ho ancora negli occhi le strie di pulviscolo dorato che fendevano la penombra. Immaginavo che da quegli scivoli di luce scendessero le fate. E un paio di volte sono certa di averle viste quelle minuscole creature fatte d’aria, vestite di petali di fiori.
Delle estati in campagna mi restano scampoli di ricordi, remoti e sgualciti dal tempo. Forse sono soltanto tracce immaginifiche e rassicuranti o rifugi fantastici, in cui cerco riparo quando sono schiacciata dalla routine. Oppure lembi di vita che hanno preso il volo verso l’infinito.
MENZIONI D’ONORE
 “Lettere dall’eternità” di Cyrcle Bob
“Lettere dall’eternità” di Cyrcle Bob
Non perfettamente in tema, ma una fantasia Felliniana ad h.o.c.. Fellini costruiva un mondo intero attorno ai personaggi, Cyrcle Bob ha costruito per loro un universo.
 “La Fontana di Trevi” di Marco Colacioppo
“La Fontana di Trevi” di Marco Colacioppo
Sarà che la Fontana di Trevi fa subito Fellini, sarà che questa mamma involontariamente trasgressiva sarebbe piaciuta a Fellini; Marco ha resuscitato il sogno della dolce vita, la magia di quel luogo e di un’Italia che credeva ancora nelle monetine.
 “Cugini fratelli” di Morgana
“Cugini fratelli” di Morgana
Com’eravamo senza Robert Redford e Barbara, in un’Italia in cui mangiare un salamino di nascosto, al cinema, era quanto bastava a due bimbi per essere amici e complici per sempre.
I VINCITORI DELLA GIURIA POPOLARE
Al secondo tentativo Luisa Di Toma vince la giuria popolare con il suo racconto originalissimo “Io non ricordo” che ribalta l’amarcord partendo dall’assenza del ricordo stesso, dal suo lento sbriciolarsi nella mente fino ad abbandonare anche il cuore. A lei il premio della giuria grazie a 96 like complessivi. Al secondo posto una veterana di BSF: Giovanna Adelaide Busacca, con un amarcord rurale, ruvido, frammentato, crudo, animalesco, come se il ricordo ce lo sussurrasse il toro in prima persona. Si è piazzata seconda con dieci like in meno. Valorosi anche gli sforzi di Marco Colacioppo, terzo con 85 tra like e cuori, e di Paola Merzaghi con 43 like complessivi.
Partecipa!
Iscriviti e partecipa!
La partecipazione richiede un pagamento di 10€ e la registrazione al sito, che la prima volta avverrà in fase di checkout.